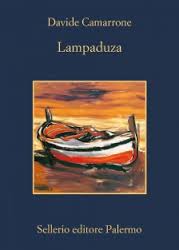 Gli arabi la chiamano Lampaduza. Ed è questo il titolo che Davide Camarrone, giornalista palermitano che lavora per la Rai ha voluto dare al suo libro. Lampaduza (Sellerio, euro 12) è una sorta di memoir nel quale l’autore ripercorre la sua personale esperienza sull’isola di Lampedusa tra il 2012 e il 2013. Racconta ciò che ha visto, le persone che ha incontrato, le parole che ha ascoltato. È un racconto emotivo ma ricco, per scelta e per deformazione professionale, di fatti, analisi e riflessioni. Camarrone amplia lo sguardo: non parla solo di migranti, ma del ruolo geopolitico che l’isola ha avuto e ha tuttóra e lo fa collegando, sebbene in maniera a volte troppo frammentaria, quello che accade oggi con la storia dei rapporti tra Nord e Sud del mondo, in particolare tra Italia e Libia. Ne abbiamo parlato con lui.
Gli arabi la chiamano Lampaduza. Ed è questo il titolo che Davide Camarrone, giornalista palermitano che lavora per la Rai ha voluto dare al suo libro. Lampaduza (Sellerio, euro 12) è una sorta di memoir nel quale l’autore ripercorre la sua personale esperienza sull’isola di Lampedusa tra il 2012 e il 2013. Racconta ciò che ha visto, le persone che ha incontrato, le parole che ha ascoltato. È un racconto emotivo ma ricco, per scelta e per deformazione professionale, di fatti, analisi e riflessioni. Camarrone amplia lo sguardo: non parla solo di migranti, ma del ruolo geopolitico che l’isola ha avuto e ha tuttóra e lo fa collegando, sebbene in maniera a volte troppo frammentaria, quello che accade oggi con la storia dei rapporti tra Nord e Sud del mondo, in particolare tra Italia e Libia. Ne abbiamo parlato con lui.
Perché ha scritto questo libro?
«Perché i giornalisti hanno il compito di spiegare e raccontare la realtà, anche quella che la gente non ha voglia di vedere. In questi anni sta avvenendo la più grande migrazione umana, uno degli eventi più rilevanti della nostra storia, non solo in termini numerici ma per il cataclisma culturale, e lo dico in senso positivo, che comporta: e bisogna parlarne. Ma in un momento storico in cui il giornalismo tradizionale non esiste più, bisogna usare, insieme agli strumenti professionali, anche le emozioni. Devi raccontare quello che vedi con toni e accenti autentici che corrispondano, per immedesimazione, a ciò che sta provando la persona che è oggetto del tuo sguardo».
Ha scelto di narrare per frammenti e a volte il lettore fa fatica a seguire il filo…
«È la realtà a essere frammentaria: a Lampedusa si concentrano, in una mistura esplosiva, le contraddizioni del nostro tempo, e a pagarne le conseguenze sono i migranti, gli operatori, gli abitanti, i giornalisti. Chiunque finisca a Lampedusa paga un prezzo. Quando io vado sull’isola ci sono molte cose che non capisco, perché c’è una straordinaria densità di eventi, una concentrazione di sofferenze, incompetenze, insufficienze. Nel libro racconto proprio questo bombardamento di sensazioni. Entri in un cimitero, vedi una tomba di un colore che non è usuale per noi italiani e capisci che dietro ci sono tante cose: il dolore di chi ha perso un figlio e non sa dov’è, perché magari nella tomba non c’è nessun corpo o c’è il corpo di un altro; la speranza; una cultura e una religione diverse dalle tue. Se hai una buona sensibilità, vivere un giorno a Lampedusa è come viverne 100 in un altro luogo».
Lei inquadra l’isola in una prospettiva più ampia, che include i suoi rapporti con il resto d’Italia e il suo ruolo geopolitico. Come mai?
«Lampedusa appartiene alla storia più straordinaria della Sicilia: da una parte è una sorta di frazione di Agrigento, sede del mito greco; dall’altra rinvia, con il suo nome, ai Principi di Lampedusa. Ma nella realtà è un luogo di emarginazione fisica e geografica, che negli ultimi decenni ha pensato di usare, per la propria rinascita, la notorietà ricevuta quando fu quasi bombardata da Gheddafi nel 1986. La faccenda dei missili è stato il frutto di un compromesso e di un rapporto mal gestito da Nord e Sud del mondo, che ha preso il posto del cattivo rapporto tra Est e Ovest e che si intreccia anche con fatti di mafia, perché in Sicilia qualunque contrapposizione la si paga in termini di utilizzo di quell’agenzia del crimine che è Cosa Nostra. Che sia obiettivo di un attacco missilistico come nell’86, o che sia la sponda a cui approda chi scappa dal Sud del mondo, Lampedusa ha sempre e comunque un ruolo di cerniera».
Scrive che Lampedusa è stata “scelta” come frontiera. In che senso?
«L’Europa ha molte porte: in Spagna, in Grecia, nei paesi della ex Jugoslavia… e anche lì succedono molte cose. Ma si parla sempre di Lampedusa. Perché tra tutte le porte, è la più illuminata».
Perché?
«Perché si è creato un circuito in cui le parti in campo (politici, funzionari) devono ritagliarsi un ruolo. Da una parte c’è l’operazione Mare Nostrum finanziata anche dall’Europa, dall’altra il continuo arrivo di migranti. Stiamo gestendo un’emergenza straordinaria con un’ipocrisia tutta italiana che è diventata anche europea. Perché è vero che i migranti arrivano in Sicilia, ma è anche vero che non si fermano. L’Italia concede poco l’asilo politico. È come se si fosse stabilita una tacita divisione dei ruoli: l’Europa paga l’Italia perché si occupi dell’arrivo. La permanenza è una faccenda che riguarda altri Paesi. E in questo gioco Lampedusa ha ricevuto la tacita consacrazione a porto di arrivo. Se noi ci occupassimo della realtà com’è e non come vorremmo che fosse, saremmo in grado di gestire la migrazione spendendo le stesse cifre, forse anche meno. Ammesso che il problema sia economico».
Non lo è?
«Non solo non lo è, ma la migrazione può essere una risorsa. Faccio un esempio. In Sicilia esiste una rete di 230 Ipab (Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza) che sono in crisi da almeno 6 anni, ma hanno personale ben formato: un capitale di immobili e professionalità che vive malamente ricevendo dalla Regione il 10% di ciò che spende. Ognuna di queste strutture può ospitare tra le 100 e le 200 persone. Se utilizzassimo i fondi europei che la Sicilia perde regolarmente perché non fa un’attività di programmazione ordinaria, per ristrutturare e rendere operativi questi istituti, potremmo trasformare un fatto di straordinario cambiamendo antropologico e culturale come le migrazioni in un’opportunità di lavoro. Sosterremmo gli Ipab e accoglieremmo queste persone in maniera dignitosa, alleviando le loro sofferenze e il trauma del viaggio. Poi le avvieremmo verso i loro luoghi di destinazione, quasi sempre diversi dall’Italia. Invece si preferisce finanziare, per gestire l’emergenza, strutture alberghiere che non sono in grado di fare politica culturale e di accoglienza».
Nel suo libro fa molte riflessioni sui siciliani e il loro atteggiamento contraddittorio nei confronti dei migranti. Ce ne parla?
«Noi siciliani siamo antropologicamente annichiliti. Siamo il frutto degli incroci tra una ventina di culture diverse, ma da secoli la nostra isola è morta. Avevamo una tradizione straordinaria di apertura al mondo, poi alla fine del 1400, tutto è cambiato. Dall’esterno sono arrivati i pirati, che ci hanno costretto a chiudere i porti e rinchiuderci in noi stessi. Dall’interno, ed è stato l’evento più grave,c’è stata l’Inquisizione, un sistema brutale che si basava sulla delazione e che ha deformato il nostro costume antropologico, rendendoci chiusi, diffidenti, paurosi, consapevoli di poter essere traditi in qualunque momento. L’unica speranza per noi è che il nostro dna sia risvegliato dalle migrazioni. Quello che sta accadendo è un’opportunità: possiamo tornare a essere come eravamo se cogliamo nelle migrazioni il segno della permanenza del nostro passato. Proiettandoci in mondi differenti dal nostro, possiamo superare secoli di chiusura e arretramento».
Questo discorso è idealmente molto bello. Ma in Sicilia esistono situazioni di degrado sociale ed economico che certamente faticano a sposarsi con l’accoglienza, non crede?
«È vero in parte. Sicuramente c’è la paura atavica dell’altro. Poi c’è anche una cattiva informazione che fa guardare ai migranti come nemici che vengono a rubare il lavoro, e in Sicilia esiste un detto che recita: “A cu’ ti leva u pani, levaci la vita”. Ma contro questi pregiudizi, forti da eliminare, c’è un altro istinto che è rimasto: quello di riconoscere le persone che, come te, hanno bisogno. E infine c’è la curiosità: noi siciliani siamo irresistibilmente attratti dal diverso, perché la diversità è già insita in noi, che portiamo i segni di appartenenze differenti e siamo mori e biondi, alti e bassi. Siamo un popolo contraddittorio, ma alla fine generoso».
Resta il fatto che l’incontro tra chi arriva e gli abitanti non si svolge sempre all’insegna della comprensione…
«Ma non appena si supera il primo scoglio, quello che ti fa pensare all’altro come a un possibile nemico, un traditore, è fatta: a quel punto restano i problemi di ogni giorno, quelli materiali, che non possono essere addebitati ai singoli. Prendiamo Lampedusa. I migranti si ritrovano trattenuti lì senza una spiegazione, senza il conforto di un mediatore formato (perché non basta prendere un caporale dell’esercito e fargli fare un corso di qualche ora: un meditore vero ha alle spalle anni di formazione e di lavoro sul campo!) e allora capita che si riversino per strada e si abbandonino a ogni sorta di eccessi, comprensibili o meno. A quel punto i lampedusani si arrabbiano, a volte anche molto. Ma poi, quando vedono i migranti nel cortile del centro, sotto la pioggia perché non ci sono abbastanza posti per accoglierli all’interno, bussano alla porta con il sacchetto della spesa in mano».
Lei paragona i campi di stazionamento in Libia a quelli di concentramento: ci vuole spiegare?
«Cinque anni fa ho scritto un romanzo dal titolo Questo è un uomo, con un chiaro riferimento a Primo Levi. Parlavo in particolare del campo di Kufra e mi ero preparato sui documenti delle Ong, dai quali appare chiaro che lì vigono le stesse logiche dei campi di concentramento. L’uomo è ridotto a un oggetto, privato della propria umanità, costretto a fare cose che detesta e per le quali si sentirà in colpa per tutta la vita. Nei campi arrivano persone che fuggono da luoghi di disperazione. A differenza di ciò che accadeva a noi italiani che migravamo con la promessa del ritorno, loro scappano per non tornare più. E si ritrovano ad attendere la partenza in luoghi atroci».
Qualcuno paragona anche i Cie ai lager, lei cosa ne pensa?
«Il paragone, in senso letterale, non regge. Ma è vero che quando l’uomo perde la nozione del senso della propria integrità, è capace di lasciarsi andare a comportamenti inaccettabili. Probabilmente le immagini delle docce all’aperto (nel dicembre 2013 si scoprì, grazie a delle foto, che nel Centro di Prima Accoglienza di Lampedusa i migranti venivano denudati e lavati con un pompa, nel cortile, in pieno inverno, ndr) raccontano una scelta inconsapevole, ma la gravità sta proprio in questo. Ci sono cose che non si fanno, punto. Non si lava un uomo, nudo, insieme ad altri uomini, con un tubo di gomma. Le intenzioni del singolo non contano: anche nei lager probabilmente c’erano persone non consapevoli della gravità di ciò che facevano: è quello che intende Hannah Arendt parlando della banalità del male. Noi ci definiamo un popolo di Santi, Navigatori ed Eroi, ma dobbiamo sapere che quando voltiamo lo sguardo dall’altra parte o quando ci lasciamo andare a un singolo gesto grave, ripetiamo in quel singolo gesto tutto il male del mondo».
Lei scrive nel suo libro di essere positivo nei confronti del futuro: perché?
«Perché questa migrazione non la fermeremo mai».
Quindi bisogna imparare a gestirla non come emergenza, ma come fatto struttuale?
«No, gestirla è il termine sbagliato: si gestisce una cosa esterna a sé, che si vuole tenere lontana. Noi invece dobbiamo imparare a vivere la migrazione, stare dentro questo processo. Altrimenti, alla fine saremo noi a essere marginali».
Gabriella Grasso

